Solo 1 persona
su 7 vive in un Paese con una stampa “libera”
Italia 64esima
insieme
a Namibia, Nauru e Cile
Umberto
Mazzantini su www.greenreport.it
| 5 maggio 2014
Secondo
il rapporto
Freedom of the Press 2014 di Freedom House, la
libertà di stampa globale
è scesa al livello più basso da oltre un decennio. Secondo il rapporto,
«La
flessione è stata determinata in parte dalla regressione della libertà
in
diversi Stati del Medio Oriente, tra cui Egitto, Libia e Giordania;
marcate battute
d’arresto in Turchia,
Ucraina, e un certo numero di Paesi dell’Africa orientale; e dal
deterioramento
nell’ambiente relativamente aperto e del sostegno ai media negli Stati
Uniti».
Stampa
davvero libera in Europa in Estonia, Lettonia,
Lituania, Finlandia, Svezia, Norvegia, Islanda, Danimarca/Groenlandia,
Gran
Bretagna, Irlanda, Francia,Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria,
Slovenia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Germania, Belgio, Olanda e
Lussemburgo,
Malta, Cipro, Andorra, Liechtestein, Monaco, San Marino. L’Italia è a
31 punti,
come la Namibia, Nauru e il Cile.
L’Europa
è laregione
che vanta il più alto livello di libertà di stampa, ma il punteggio
medio
regionale ha registrato il secondo più grande calo del
mondo nel 2013., in particolare per gli
attacchi alla stampa ed ai nuovi media in Turchia, Grecia, Montenegro e
Gran
Bretagna. In Italia la
situazione è
leggermente migliorata con l’uscita di Silvio Berlusconi dal governo, ma «Rimane tra i
parzialmente liberi».
In
Eurasia (ex Urss) il
97% delle
persone vive in
ambienti Not Free media. In Russia
le
condizioni di libertà di stampa non sono buone, l’agenzia di stampa Ria
Novosti
è passata sotto il totale controllo del governo che ha promulgato
ulteriori
restrizioni legali alla libertà di parola online. L’Ucraina nel 2013 è
stata
declassata a “Not Free” soprattutto a causa degli attacchi contro ai
giornalisti che hanno coperto prima le proteste di Euromaidan ed ora
quelle
filo-russe. Un’’ulteriore erosione della libertà di stampa ha avuto
luogo in
Azerbaigian, mentre sviluppi positivi co sono stati in Kirghizistan e
in
Georgia.
In
America in Canada,
Usa, Giamaica, Belize, Bahamas, Barbados, Saint Lucia, Saint Vincent e
Grenadines, Saint Kitts e Nevis, Grenada, Dominica, Trinidad e Tobago,
Costarica, Suriname, Uruguay. Nelle Americhe la media regionale è al
livello
più basso degli
ultimi 5 anni, e solo il
2% della popolazione dell’America Latina
vive in un ambiente mediatico libero. I cali più
grossi per la libertà
di stampa sono avvenuti in Honduras, Panama, Suriname e Venezuela,
mentre è
migliorato il punteggio del Paraguay. Le condizioni negli Usa si sono deteriorate
soprattutto per i tentativi
del governo di inibire le notizie sulle questioni di sicurezza
nazionale.
In
Africa la piena libertà di stampa esiste solo a Capo
Verde, Ghana, Sao Tomè e Pincipe, Mauritius.
In
Medio Oriente e Nord Africa solo il 2% della popolazione
vive in ambienti con media
liberi, mentre
la stragrande maggioranza, l’84% vive in paesi o territori non liberi.
I
regressi peggiori ci sono stati in Libia ed Egitto, mentre un
deterioramento
significativo ha avuto luogo in Giordania e in misura minore in Iraq ed
Emirati
Arabi Uniti. La libertà di stampa è ulteriormente diminuita in Siria,
nel bel
mezzo di una guerra civile particolarmente brutale che pone enormi
pericoli per
i giornalisti. Miglioramenti solo in Algeria,
Yemen, la Cisgiordania e Striscia di Gaza e Israele,
che torna tra i
Paesi v con la stampa totalmente libera.
Nell’Africa
sub-sahariana la maggioranza delle persone (56%)
vive in Paesi con media
parzialmente liberi.
Nel 2013 i
miglioramenti giuridici ed economici sono stati bilanciati da
peggioramenti di
tipo politico, in particolare per i giornalisti la situazione si è
fatta più
difficile in Sud
Sudan e Zambia, Repubblica
Centrafricana ed in diversi Paesi
dell’Africa orientale, tra cui Kenya, Mozambico, Tanzania e Uganda.
L’Africa
occidentale ha visto una serie di miglioramenti, compresi quelli in
Costa
d’Avorio, Mali,
Senegal e Togo. Un
miglioramento della classifica lo hanno fatto registrare anche
Repubblica
democratica del Congo, Madagascar, Seychelles e Zimbabwe.
In
Oceania godono di libertà di stampa Australia, Nuova
Zelanda, Papua Nuova Guinea, Palau, Isole Marshall, Micronesia,
Vanuatu,
Tuvalu, Tonga, Kiribati, Samoa In
Asia
un vera Libertà di stampa c’è solo in Giappone,
Taiwan ed Israele (ma qui siamo al limite, proprio
davanti all’Italia).
Nonostante
l’ottima performance democratica di praticamente
tutta l’Oceania, nell’Asia-Pacifico solo il 5% della popolazione ha
libero
accesso ai mezzi di informazione. La Cina continua a reprimere la
circolazione
di notizie online, in particolare sui microblog, ed ha aumentato la
pressione
sui giornalisti stranieri. La libertà di stampa si è deteriorata ad
Hong Kong,
India, Sri Lanka, Thailandia, e molti Stati insulari del Pacifico, tra
cui
Nauru, che è stato declassati. Birmania
e Nepal registrano
un miglioramento del
loro punteggio.
Per
Freedom of the Press 2014, nonostante
gli sviluppi positive in un certo numero di
Paesi, in particolare nell’Africa sub-sahariana, i trend dominanti
riflettono
battute di arresto in ogni altro continente.
Il
paradiso della libertà di stampa è l’Europa: la top ten
vede ai primi tre posti a pari merito Olanda, Norvegia e Svezia,
seguono Belgio
e Finlandia, Danmarca/Groenlandia Islanda, Svizzera e Lussemburgo, e
chiude
Andorra. Gli Usa sono solo al 30esimo posto. Per trovare l’Italia
bisogna
scendere al 64esimo.
All’ultimo
posto, 197eseima c’è la Corea del nord, preceduta
da Uzbekistan, Turkmenistan, Eritrea, Bielorussia, Iran, Cuba, Guinea
Equatoriale, Siria, Bahrain. La
Cina è
poco lontana, 183esima, separata dai peggiori 10 solo da Vietnam e
Kazakistan.
La Cina e la Russia (176esima insieme a Sudan ed Etiopia) hanno
mantenuto uno
stretto controllo sui media locali, mentre tentano anche di controllare
i punti
di vista più indipendenti sia nella blogosfera che da fonti di notizie
straniere.
In campo la
storia si ripete
John Foot su
Internazionale | 5 maggio 2014
Dopo
i fatti avvenuti allo stadio Olimpico il 3 maggio,
avrei potuto semplicemente segnalare un altro articolo scritto in
passato,
perché non è cambiato nulla. Non cambia mai niente nel mondo del calcio
italiano. L’altra sera, però, è stata esemplare: un esempio
dell’ordinaria
follia di questo sport che è circondato da una logica che lo porta
verso
l’autodistruzione, pochi giorni dopo la notizia che l’Italia è ormai
dietro
perfino al Portogallo nella classifica europea.
Un film già
visto. Ecco quello a cui abbiamo assistito (otto
milioni di spettatori in Italia, più altri all’estero, poverini). Prima
le
notizie (contrastanti) sugli scontri in città tra i tifosi, poi
addirittura gli
spari e le persone ricoverate in ospedale in codice rosso. Poi la
confusione totale.
I tifosi (ultrà e no) sono dentro lo stadio. Ci sono anche Matteo Renzi
e altri
vip. Twitter comincia ad agitarsi. I giornali pubblicano informazione e
disinformazione.
Fin
qui è tutto abbastanza normale (a parte gli spari,
esagerati perfino per il calcio). Ci sono scontri ogni settimana, e
accoltellamenti intorno allo stadio, soprattutto a Roma. Non fanno
neanche
notizia, ormai. Ma questa è una partita importante, e la possibilità
che ci sia
una persona morta cambia le carte in gioco. È morto o non è morto? Se è
morto,
giochiamo? Comincia il solito discorso sul giocare o non giocare, come
se la
partita fosse la cosa più importante, quasi sacra, in grado di “portare
l’ordine” ed “evitare il caos”.
Arriva
in campo un miliardario. Il capitano del Napoli,
Marek Hamšík. Quello con la cresta (che più tardi diventerà blu).
Hamšík è
scuro in faccia, sembra che abbia quasi paura. Va verso la curva. Che
sta
facendo? Perché sta parlando con quel tifoso grosso, con i tatuaggi e
la
maglietta con scritto “Speziale libero”? Molti vanno sul Google per
scoprire
chi è Speziale. È l’uomo condannato in via definitiva per l’uccisione
di un
poliziotto, Filippo Raciti, fuori da un (altro) stadio. Otto milioni di
italiani assistono a questa scena, incluso Matteo Renzi. Di che stanno
parlando? È una trattativa o no? Chi comanda?
Il Corriere
della Sera, il più blasonato giornale italiano,
fa un titolo sul sito: “Ecco cosa è successo”. C’è un filmato sfocato
in cui
non si capisce assolutamente niente, privo di commenti. Giornalismo di
alto
livello, ma magari erano tutti fuori per il ponte.
I
giornalisti parlano di clima surreale. Macché surreale:
questa è l’assoluta normalità. Gli ultrà compiono i loro riti
(striscioni
abbassati eccetera) per mandare precisi segnali. Si gioca? Non si
gioca? Gli
scontri sono estranei al mondo del calcio o no? Ci sarebbero stati
senza la
partita o no? Poi segue la solita ondata di retorica. “Delinquenti, non
tifosi”, “Queste scene non hanno niente a che fare con il calcio” (e
invece
sì), “Incredibile” (ma non e incredibile per niente, è la routine). Un
altro
tifoso si siede sopra la barriera. Sta lì, sospeso nel vuoto. Secondo
il
commentatore Mario Somma, ha “bisogno di spazio per dirigere i cori”.
Poi
la decisione è presa. Da chi, non si sa. Ma sembra
chiaro che il capo della tifoseria (un privato cittadino, come uno di
noi) ha
avuto qualche peso nella decisione. Ormai è una star, il suo nome fa il
giro
del web. È un soprannome: il grande, indimenticabile, Genny ’a carogna.
Poi
si gioca una partita di calcio: ci sono tiri, passaggi,
contrasti, fischi, espulsioni. Vince il Napoli, 3-1. Alzano la coppa.
Adesso
Hamšík ride. Ha tinto la cresta di blu. Ci sono perfino dei commenti
tecnici.
La sacralità è stata rispettata, anche se l’appello del papa è stato
abbastanza
inutile. E ora? Il solito, inutile, giro di retorica e ignoranza, con
commenti
(disinformati) sul modello inglese e il modello tedesco. A me fanno le
stesse
domande da vent’anni.
Un
film già visto, come dicevo.
Basta
leggere qualcosa sul passato. Ecco qualche indizio:
Paparelli (1979), Heysel (1985), Claudio Spagnolo (1995), il derby del
bambino
morto (2004), Raciti (2007), Sandri (2007).
Aspettiamo
la prossima volta. Sarà più o meno uguale.
Una
Costituzione riscritta dai bidelli
L’Italicum
vuole
sfacciatamente favorire i due maggiori partiti. Il nuovo Senato è un
pasticcio
senza capo né coda, destinato a produrre solo caos. Questo accade
quando le
riforme finiscono in mano ai dilettanti
Marco
Travaglio su l'Espresso
| 5 maggio 2014
Appena
uno si azzarda a mettere in dubbio la bontà della
riforma elettorale “Italicum” o di quella del Senato, il premier e la
sua
vestale Maria Elena Boschi arrotano le boccucce a cul di gallina: «Il
patto del
Nazareno non si tocca». Trattasi dell’accordo siglato da Renzi e
Berlusconi
(attualmente detenuto ai servizi sociali) il 18 gennaio nella sede del
Pd. Che,
complice la toponomastica, evoca un che di sacrale: roba da tavole
della legge,
da arca dell’alleanza. Chiunque osi discostarsene - il presidente del
senato
Piero Grasso, o i giuristi di Libertà e Giustizia, o il mite Vannino
Chiti
trattato ormai come un brigatista rosso - viene subito bollato di
“rosicone”,
“gufo”, “professorone”, “solone milionario”, “conservatore” e nemico
del
“cambiamento”. Il fatto è che questo patto Ribbentrop-Molotov
all’amatriciana
tutti lo evocano, ma nessuno - a parte i due firmatari, più Boschi e
Verdini -
lo conosce. Renzi ha appena annunciato la “total disclosure” sulle
stragi di
40-50 anni fa, cioè la revoca del segreto di Stato, che però copre al
massimo
fatti di 30 anni fa, escluse le stragi, dunque non esiste. Ma forse
farebbe
cosa più utile a desegretare il Patto del Nazareno, così finalmente
sapremmo
cosa c’è scritto e potremmo regolarci.
L'Italicum
è notoriamente una boiata pazzesca che riproduce
e talora peggiora i vizi del Porcellum, già bocciati dalla Consulta:
liste
bloccate con deputati nominati dai segretari di partito e premio di
maggioranza-monstre per chi arriva primo, con spaventose soglie di
sbarramento
per escludere chi non s’intruppa. Però almeno si comprende la logica
brutalmente partitocratica e semplificatoria dei due partiti - Pd e
Forza Italia
- che l’hanno partorito. La riforma del Senato, invece, è una porcata
di cui
sfugge pure la logica. E siccome persino Forza Italia se n’è resa
conto, ed è
sempre più tentata di appoggiare il testo di Chiti (che piace anche ai
5Stelle), è giocoforza chiederne conto agli unici genitori rimasti:
Renzi e la
Boschi.
Diamo
pure per scontato ciò che non lo è affatto, e cioè che
il nuovo “Senato delle autonomie” non sia più elettivo, non voti più la
fiducia
al governo e non possa esprimere che pareri consultivi sulle leggi
votate dalla
Camera (a parte quelle costituzionali). E cerchiamo di dare un senso
alla sua
nuova composizione: cioè alle modalità di accesso dei 148 senatori. I
primi 21
li nomina il capo dello Stato (in aggiunta ai 5 senatori a vita): ma
che senso
ha che il 15 per cento dei membri del Senato li nomini una sola
persona? Altri
21 saranno i governatori delle 19 regioni e i 2 presidenti delle
province
autonome di Trento e Bolzano. Altri 21 saranno i sindaci dei capoluoghi
di
regione e di provincia autonoma. Altri 40 verranno scelti fra i
consiglieri
regionali: 2 per regione. E altrettanti fra i sindaci: 2 per regione.
Ma
perché mai tutta questa brava gente - in parte non
eletta, in parte eletta per fare tutt’altro - dovrebbe approvare le
leggi costituzionali
ed eleggere il capo dello Stato, i membri del Csm e della Consulta? E,
se tutti
questi signori dovranno trascorrere metà della settimana a Roma, non
rischiano
di essere dei senatori e degli amministratori locali a mezzo servizio,
svolgendo male l’un compito e l’altro? Siccome poi pochissimi saranno
residenti
a Roma e tutti gli altri in trasferta, andranno rimborsati per i viaggi
e i
pernottamenti nella Capitale, riducendo i già magri risparmi (50-80
milioni
all’anno) ricavati dall’abolizione del Senato elettivo e retribuito. La
Valle
d’Aosta, poi, avrà tanti senatori quanti la Lombardia, che ha 80 volte
i suoi
abitanti, e così il Molise con la Campania, 20 volte più popolosa.
Anche questa
scemenza è scritta col sangue nel Patto del Nazareno, o se ne può
discutere?
Infine,
last but not least, il Senato dura cinque anni, ma
nelle regioni e nei comuni si vota in ordine sparso, sicché ogni anno
qualche
governatore e sindaco perde il posto. E Palazzo Madama diventa un
albergo a ore
con le porte girevoli, dove si entra e si esce. E le maggioranze sono
affidate
al caso. O al caos.
Cose che
càpitano quando, a furia di disprezzare i
professori, la Costituzione la riscrivono i bidelli.
Il lavoro non
si festeggia
Andrea
Fumagalli su www.alfabeta2.it
| 1 maggio 2014
Il 1° maggio
(con l’eccezione degli Usa) è notoriamente la
festa del lavoro. Il che significa che il lavoro va festeggiato ed è
oggetto di
festa. Un tempo, il lavoro veniva festeggiato in quanto strumento di
emancipazione, in grado di fornire i mezzi monetari (reddito) e i
diritti di
cittadinanza per poter godere del tempo del non-lavoro, ovvero
dell’ozio, nel
suo più nobile significato (otium).
Era
un tempo in cui la separazione tra lavoro e non lavoro
era ben chiara e netta. Tale distinzione derivava da un’altra
distinzione,
funzionale al processo di accumulazione e valorizzazione capitalista:
quella
tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo, da cui discendevano i
parametri
che decidevano quali attività umane dovevano essere remunerate in
moneta e
quali no (come, ad esempio, il lavoro di riproduzione).
Oggi
tutta la vita è messa a lavoro e a valore, ovvero è
vita produttiva, sempre più inserita nel processo di mercificazione che
accomuna tutte le attività umane, da quella artistica a quella manuale.
La
svalorizzazione dell’attività creativa-cognitiva, emblema della
produzione
contemporanea, è oggi archetipo delle mutate condizioni di
valorizzazione e
delle trasformazioni del lavoro. Il lavoratore creativo-cognitivo,
infatti,
lavora tutto il giorno, ma viene pagato (e impiegato) solo raramente e,
per di
più, solo se è disposto ad alienare formazione e competenze in funzione
della
domanda e delle ideologie dei pochi committenti rimasti. Per il
lavoratore
creativo-cognitivo, il 1° maggio non può essere dunque la festa del
lavoro.
Ma
la stessa situazione la vive chi presta lavoro manuale.
Le recenti vicende che hanno visto protagonisti i lavoratori, migranti
e non,
delle cooperative (molte delle quali legate a Lega Coop, il cui ex
presidente è
oggi ministro del lavoro), dalla Granarolo di Bologna, all’Ikea di
Piacenza e
all’Esselunga di Milano, solo per citare alcuni esempi, hanno
evidenziato come
il livello di precarietà e quindi di sfruttamento, con paghe orarie da
fame
(sino ai 2,80 euro dei lavoratori della Coopservice, nell’indotto dei
servizi
dell’Università di Bologna), è oramai un fatto esistenziale, che
tracima la
stessa condizione lavorativa.
Poco
meno di un anno fa, il 23 luglio 2013, veniva siglato
un accordo tra Cgil, Cisl, Uil, Expo Spa e Comune di Milano per
assumere 700
giovani con contratti di apprendistato e a termine, in deroga alle
norme
vigenti all’epoca (riforma Fornero), e ben 18.500 volontari gratis in
vista del
megaevento di Expo Milano 2015. Tale accordo ha anticipato a livello
locale ciò
che poi si è esteso a livello nazionale con la riforma del jobs act:
liberalizzazione acausale del contratto a tempo determinato con
l’obiettivo di
farlo diventare il contratto di lavoro standard in sostituzione di
quello
stabile, e trasformazione del contratto di apprendistato in contratto
di
inserimento per i giovani meno qualificati, a stipendio inferiore
(-30%) e con
agevolazioni contributive solo per le imprese.
Il
1° maggio di quest’anno – coincidenza non casuale –
dovrebbe entrare in vigore il progetto Garanzia Giovani, con lo scopo,
sulla
base delle indicazioni europee, di trovare un’occupazione a più di
600.000
giovani che hanno terminato gli studi, non lavorano e non fanno
formazione (i
famosi Neet). Nulla di male, se non fosse che tale occupazione si
tradurrebbe
in prestazioni di servizio civile, corsi di riqualificazione e
volontariato.
Come aveva anticipato l’accordo per l’Expo Milano 2015, si tratta di
giovani
precari che lavorano gratis o, nella migliore delle ipotesi,
sottopagati.
Se
le cose stanno così, c’è veramente poco da festeggiare.
Oggi il 1° maggio non può essere più la festa del diritto al lavoro.
Dovrebbe
trasformarsi, se di festa si tratta, in festa del non-lavoro e del
reddito di
base, ovvero richiesta di libertà di scelta del lavoro e di
autodeterminazione
di vita, contro l’imperante ricatto sempre più massiccio della damnatio
del
lavoro per sopravvivere.
Non
sarà un caso che il termine “lavoro” etimologicamente
significhi “dolore”, “pena”, “tortura” e che oggi non implichi più
dignità ma
povertà. E non sarà un caso che negli ultimi anni in Italia la
manifestazione
più partecipata del 1° maggio non è il tradizionale corteo mattutino
indetto dai
sindacati tradizionali bensì la MayDay Parade di Milano, appunto una
parade,
festa del reddito e del non-lavoro.

 5 maggio
2014
5 maggio
2014
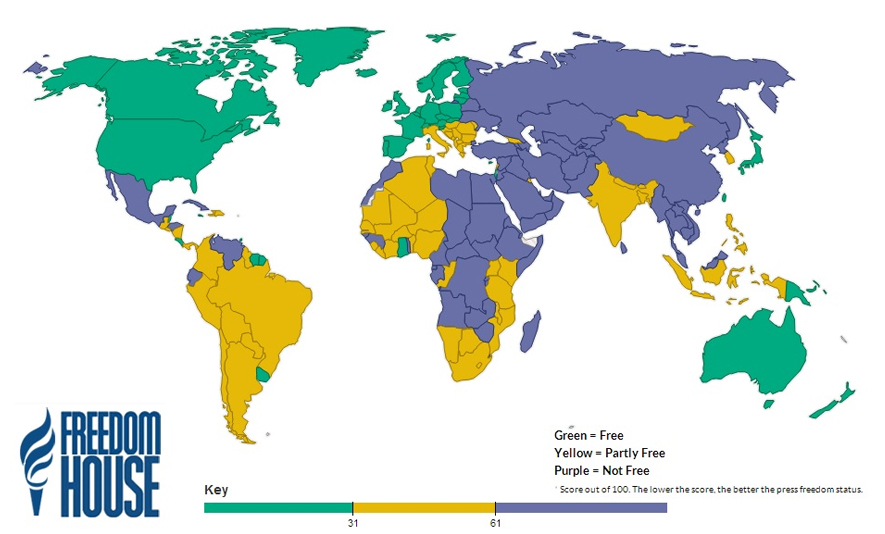
![]() 5 maggio
2014
5 maggio
2014