|
Immagini
Giovanni
De
Mauro su Internazionale
| 10 ottobre 2014
Domenica
scorsa
il giornale londinese Independent on Sunday
è uscito con la prima pagina nera e un breve testo in cui annunciava
che non
avrebbe pubblicato nessuna foto dell’esecuzione di Alan Henning, il
cooperante
britannico rapito in Siria. Sono immagini terribili quelle che arrivano
in
queste settimane dal gruppo Stato islamico: decapitazioni,
crocifissioni,
esecuzioni di massa. Servono a spaventare e a impressionare. Sono
propaganda.
Ma vengono da regioni in cui per i giornalisti e gli osservatori
indipendenti è
diventato impossibile lavorare, quindi sono spesso le uniche
disponibili. È
giusto farle vedere?
“Tutti
devono
sapere”, è l’argomento usato da chi le
pubblica. La realtà è che si tratta di trovare il punto di equilibrio
tra il
dovere d’informare, il rispetto della dignità delle vittime, il
tentativo di
evitare di essere usati come veicolo di una propaganda odiosa e
violenta.
“Perché c’è voluto così tanto tempo prima che i mezzi d’informazione
riconoscessero gli enormi problemi etici legati al mostrare queste
immagini?
Come giornalisti abbiamo la responsabilità di parlare di queste
uccisioni, ma
non dobbiamo riprodurre in modo automatico la peggiore propaganda”, ha
scritto
Joan Smith, di Hacked Off, sull’Independent on Sunday. Sono immagini
talmente
violente che, raccontano all’agenzia di stampa France-Presse, i
giornalisti che
devono esaminarle ne sono sconvolti.
Non
c’è
un’unica risposta giusta, ma ogni mezzo
d’informazione è chiamato a dare la sua e possibilmente a renderla
pubblica.
Internazionale quindi si unisce alla decisione dell’Independent on
Sunday:
continueremo a informare sul gruppo Stato islamico, ma non
pubblicheremo più
quelle immagini.
Kobane:
Bring the war home
Gab
Carrol su connessioniprecarie.org
| 10 ottobre
2014
Ogni
volta che
si scrive di Kobane si teme di arrivare
troppo tardi, che il tempo della città nel frattempo sia scaduto. Ma la
città
resiste ancora. Un motivo è sicuramente l’aumento di raid aerei della
«Coalizione anti-Isis» negli ultimi giorni. Ma il fattore determinante
continua
a essere la feroce resistenza delle YPG/YPJ che, pur subendo e perdendo
tanto e
senza rinforzi da quasi un mese, non hanno smesso di combattere
l’avanzata
jihadista. Notizie degli ultimi due giorni parlano di un blocco
parziale
dell’avanzata dell’ISIS, che controllerebbe il 15-20%
(altri dicono un terzo) della città. Le
YPG/YPJ riportano scontri anche in un altro villaggio del cantone,
Dehma. La
Turchia rimane ferma nel suo rifiuto di stabilire un corridoio
umanitario-militare che, attraversando il suo confine, permetterebbe ai
rinforzi (anche eventualmente, secondo alcune fonti, ai peshmerga
iracheni) di
raggiungere la cittadina assediata, insieme agli aiuti umanitari.
Mercoledì la
polizia turca ha arrestato 5 membri del PYD vicino al confine,
accusandoli di
appartenere a un’organizzazione terrorista. Diverse dichiarazioni
ufficiali
turche hanno sostenuto la necessità che Kobane non cada in mano «di
gruppi
terroristi». Il plurale è chiaramente riferito alle YPJ/YPG, indicando
un’equidistanza politicamente inaccettabile, ma per niente
sorprendente. Sembra
proprio che l’autodeterminazione di Rojava faccia paura quanto, se non
più
dell’avanzata dello Stato Islamico.
L’appello di
Salih Muslim (presidente del PYD) del 6 ottobre
non è però caduto nel vuoto. Le comunità curde di mezzo mondo si sono
mobilitate e in Turchia è esplosa una vera e propria rivolta. Non solo
nelle
zone curde, manifestazioni e scontri stanno avvenendo anche a Istanbul
e Ankara
e come pure in altre città, con la partecipazione e il sostegno di
pezzi
consistenti della sinistra radicale turca e dei movimenti studenteschi.
Gli
scontri (che in più di un’occasione sono stati scontri a fuoco) hanno
visto già
almeno 30 morti (compresi membri della polizia turca). Il livello dello
scontro
e il numero di morti non sono dovuti solo alla risposta brutale della
polizia
turca (immortalata in più di un caso mentre scandisce slogan pro-ISIS
durante
le sue azioni repressive), ma anche agli scontri (anche qui armati) con
squadracce islamiste (sia curde che turche) e nazionaliste. Di fronte
all’intensità del conflitto in Turchia, le decine e decine di
manifestazioni,
le occupazioni (come quella del parlamento olandese) e i blocchi
realizzati dalle
comunità curde in Europa e i primi cenni di una risposta armata del
PKK, viene
in mente uno slogan, una tattica per niente nuova, ma evidentemente
sempre
efficace: Bring the war home. Rojava-2-700x325Le forze curde del KCK,
vedendo
le YPG/YPJ assediate militarmente e mediaticamente a Kobane, e vedendo
gli
altri cantoni di Rojava a rischio, hanno voluto portare nei quartieri e
nelle
città turche la realtà dell’assedio di Kobane, mettendo a nudo le
contraddizioni dello Stato turco e della «Nuova Turchia» di Erdogan.
Quest’ultimo ha voluto isolare e far morire le rivendicazioni di Rojava
nella
Kobane assediata dallo Stato Islamico, e invece se le è trovate sotto
casa. Le
divisioni che emergono in questi scontri non sono assolutamente di
natura
etnica, tra turchi e curdi, ma politica, tra un movimento di massa
multietnico,
incarnato dall’HDP e da altre realtà nate o rafforzate dall’esperienza
di Gezi
Park – che sostiene la lotta a Kobane scendendo in strada, traducendo
notizie,
facendo appelli, organizzando manifestazioni, creando comitati di
sostegno – e
una destra reazionaria, in cui convergono interessi islamisti,
nazionalisti e
neoliberisti, che purtroppo ha anche un discreto sostegno popolare
(come
dimostrato dalle ultime elezioni). Entrambi i protagonisti di questo
scontro
esibiscono caratteri globali: sia il movimento di massa sia il governo,
infatti, non esprimono solamente una specificità turca, ma evidenziano
caratteri che emergono con intensità diverse in ogni scontro politico
tra i
movimenti contemporanei e i governi neoliberali siano essi di destra o
di
sinistra. Le mobilitazioni in Europa hanno perciò assunto forme più
pacifiche o
legate alla disobbedienza civile, riuscendo però nell’intento di
diffondere la
notizia e la rabbia dell’assedio e della resistenza in atto. Di fronte
queste
manifestazioni si può dire che qualcosa si sta muovendo al di qua di
Kobane.
Purtroppo
sembra però ancora improbabile che le YPG/YPJ
riescano a impedire la caduta di Kobane. Detto questo, si può ribadire,
senza
rischio di cadere in romanticismi, che la resistenza armata di Kobane
non è un
gesto inutile, disperato o vano, ma carico di un significato globale:
storico,
politico e materiale. Ogni giorno, ogni ora di resistenza, offre
speranza ai
cantoni liberi di Rojava, ma anche a tutte le forze laiche, socialiste
e
rivoluzionarie della regione, e non solo. Lo Stato Islamico ha
dichiarato
guerra a ogni forma di autodeterminazione e di pluralismo, e le YPG/YPJ
hanno
risposto alla guerra con la guerra, dimostrando che anche chi combatte
e muore
per il «qui e ora» può resistere a chi mira al paradiso, che è
possibile vivere
e lottare insieme nonostante differenze etniche e religiose. Un appello
diffuso
ieri dalla Rete Kurdistan faceva intuire le potenzialità di una
coalizione popolare
internazionale contro ISIS, che trova espressione nella rivoluzione di
Rojava,
la resistenza di Kobane e tutte le realtà, a livello transnazionale,
che li
sostengono e che si riconoscono in essi. Ciò significa che il contrasto
all’Isis non è il monopolio di una coalizione tra Stati che
improvvisamente si
sono accorti che la civiltà è in pericolo. Soprattutto le combattenti
di Rojava
rendono evidente che i barbari che loro combattono non sono proprio gli
stessi
affrontati da una coalizione che ieri per salvaguardare i suoi
equilibri
interni ha dichiarato Kobane un obiettivo non strategico. Per i
movimenti
globali, invece, Kobane è strategica: non per la posizione che occupa
nel
teatro di guerra, ma per ciò che la tiene in vita e la muove, per ciò
che fa esistere
fuori Kobane, per il «qui e ora» che ci chiama a vivere.
Il processo
politico avviato a Rojava, prima ancora di
diventare oggetto di discussione e di confronto (cosa auspicabile ma al
momento
resa difficile da altre contingenze), dev’essere difeso. Le
mobilitazioni che
si stanno moltiplicando in questi giorni in Europa sono importanti per
il qui e
ora e guardando in avanti. È importante che queste mobilitazioni si
coordinino
con le comunità curde già presenti e attive nei territori, seguano le
indicazioni
politiche delle YPG/YPJ, e si mettano in contatto con i comitati locali
turchi
(come quelli del HDP) che stanno già organizzando campagne di sostegno
materiale, politico e umanitario. La necessità di un corridoio
umanitario/militare a Kobane è urgentissima, ha senso diffonderla e
portarla
nelle piazze dove si dà voce e forma al sostegno per Kobane.
Jobs Act, nel
Pd scatta la resa dei conti
Walter Tocci è
graziato: «il suo è un comportamento inappuntabile». I renziani però
sono
imbufaliti con chi non ha votato la fiducia al provvedimento sul
lavoro. Per
Giachetti «bisogna prendere atto della fuoriuscita dal Pd» di Mineo e
compari.
Carbone richiede una direzione: «non basta decidere nei gruppi
parlamentari»
Luca
Sappino su
l'Espresso
| 9 ottobre 2014
Per
Walter
Tocci, si sceglierà la clemenza. Con ogni
probabilità le dimissioni saranno respinte dall’aula, come da prassi, e
anche
nel Partito, avendo Tocci votato comunque la fiducia sul jobs act, non
ci
saranno provvedimenti disciplinari. La ratio la spiega Roberto
Giachetti:
«Conosco Walter Tocci da tanti anni ed ero certo che anche in questa
occasione
avrebbe avuto modo, nella difficile situazione nella quale si è
trovato, di
confermare la sua integrità e la sua moralità politica». Anche il
renzianissimo
vicepresidente della Camera quindi dice «nel mio piccolo, lavorerò
affinché si
realizzino le condizioni politiche per il superamento delle sue
dimissioni».
All’Espresso
anche Ernesto Carbone, membro della segreteria
Pd, dice «non possiamo che apprezzare la condotta di Tocci». Tocci è
salvo,
dunque. Certo dovrà trovare il modo di restare nel Pd, convivendo con
il
maldipancia, «ma sulla fiducia si è comportato in maniera impeccabile».
Per
gli altri,
invece, per Felice Casson, Lucrezia Ricchiuti
e Corradino Mineo la situazione è più complessa. E Casson e Ricchiuti
imparano
così ad accompagnarsi a Corradino Mineo, che - è noto - sta assai poco
simpatico al premier e ai suoi: «Specularmente» dice infatti Giachetti,
«appare
chiara la scelta di uscire dal Pd compiuta da chi non ha votato la
fiducia».
Per Giachetti la questione è seria: «Qui non è in discussione la pur
grave
decisione di non votare secondo le decisioni assunte a maggioranza in
direzione
e nel gruppo al Senato». «Qui» dice, «si è scelto di non votare la
fiducia
mettendo a rischio la tenuta stessa del governo». Per Giachetti,
insomma,
cacciare i dissidenti è dunque l’unica via: «Se non si prendesse atto,
con una
decisione formale, della fuoriuscita dal Pd di chi ha compiuto questa
scelta il
Pd diventerebbe un partito sciolto più che liquido».
Giachetti
fa
quindi un passo in più del vicesegretario
democratico Lorenzo Guerini per cui il tema dei dissidenti «sarà
affrontato
nell'assemblea del gruppo Pd al Senato», che quindi deciderà. Certo è
che,
anche per Guerini, «non partecipare a un voto di fiducia, che è
politicamente
molto significativo, mette in discussione i vincoli di relazione con la
propria
comunità politica». Anche Carbone sottolinea il punto: «Mineo aveva già
avuto
motivi di attrito con la maggioranza» spiega all’Espresso, «ma questa
volta si
tratta di un voto che è l’atto più importante che può fare un
parlamentare».
Si
tratta
soprattutto, «del nostro governo» dice Carbone. E
se gli fai notare che il governo, in realtà, è anche di Angelino Alfano
e
Maurizio Sacconi, e che questo non è certo il governo per cui gli
elettori
hanno votato il Pd, e quindi anche Mineo, Casson e Ricchiuti, lui ti
risponde
che «sì», in effetti è così, «ma noi di questo governo siamo gli
azionisti di
maggioranza».
Il
comportamento di Casson, Mineo e Ricchiuti (e con loro
quello di chi non voterà alla Camera, come ad esempio dovrebbe fare
Pippo
Civati), «dovrà esser discusso nei gruppi ma anche in direzione». Una
sorta di
processo, o almeno un confronto «per stabilire come si sta in una
comunità», e
per capire cosa succede a chi infrange le regole: «decideremo» dice
Carbone,
che non vuole anticipare la sentenza. Una cosa comunque è certa, non
vale, come
attenuante, dire che nel programma del Pd non ci fosse questa riforma
del
lavoro: «I programmi cambiano, i partiti decidono cosa fare di volta in
volta»
dice ancora Carbone, «la direzione e gli organismi dirigenti del
partito
esistono proprio per questo».
Più che
Thatcher, ricorda Garrincha
Alessandro
Gilioli su Piovono Rane
| 8 ottobre 2014
Tendo
a
diffidare delle analogie storiche. Tipo il
“Berlusconi come Mussolini” che andava qualche tempo fa. Tendo a
diffidarne
perché invece tutto è sempre diverso: e l’analogia storica è spesso una
pigrizia mentale. È un modo per ricondurre il presente al passato,
quindi per
autoconfermarsi nei propri paradigmi, nelle proprie ortodossie. Come
Giampaolo
Pansa, che ogni volta che vede quattro antagonisti in piazza strilla al
ritorno
delle Brigate Rosse, per capirci.
Tre
anni fa
Eugenio Scalfari diceva che Renzi gli ricordava
Craxi. Adesso Camusso lo paragona a Thatcher.
Ecco,
anche qui
si tratta di intendersi, credo.
Il
paragone con
Craxi era dettato dai modi bruschi per
raggiungere il potere: il famoso decisionismo; e dall’apologia
mediatica
sfrenata verso il modernismo e il nuovismo. Quindi un po’ ci sta, il
confronto,
okay. Ma si parla di una somiglianza soprattutto cognitiva e
prepolitica, più
che programmatica. Craxi – prima di diventare semplicemente il capo di
una
banda di arraffoni – aveva un’idea: quella di affrancare l’Italia dal
dualismo
tra le due chiese, quella cattolica e quella comunista. Rappresentate
da Dc e
Pci. Immaginava se stesso come leader laico e socialdemocratico in una
sorta di
capitalismo dal volto umano. Il nuovismo di facciata del suo Psi (a
volte
ridicolo, come per le famose discoteche di De Michelis) aveva insomma
dietro
uno straccio di progetto politico. Che in qualche modo, viste le
difficoltà del
Pci a emanciparsi dalle sue radici sovietiche, aveva perfino un senso.
Poi i
socialisti sono diventati un’associazione per delinquere, ed è finita
lì.
Pure
Thatcher
aveva un progetto politico, cacchio se ce
l’aveva. Liberare gli spiriti animali del capitalismo, togliere le
tutele a chi
stava nei gradini più bassi, smantellare lo stato sociale in favore di
un
individualismo purissimo. Nemmeno la parola “società” era più
tollerata. Ma non
c’è bisogno di descriverlo troppo, quel progetto, perché si è quasi
tutto
avverato. E non solo nel Regno Unito.
Ho
un po’
schematizzato, su entrambi. Ma era per ricordare
che quelli avevano (Dio mi perdoni) una visione.
Renzi
no.
Renzi
è uno
straordinario ed efficace improvvisatore. Capace
di cambiare idea su tutto. In poche ore. A seconda del vento, della
convenienza, del consenso. Soprattutto del consenso.
Un
giorno sta
con la grande impresa e le banche, un altro
giorno con la piccola impresa strozzata dalle banche. Un giorno coi
precari, un
giorno coi dipendenti. Un giorno con i laici, un giorno coi cattolici.
Un
giorno con Landini, un altro con Marchionne. Un giorno con il ‘basta
casta’, un
giorno con il ceto politico. Un giorno con i boiardi di Stato, un
giorno
contro. E così via, all’infinito.
È
uno zigzag
ubriacante. Neanche Garrincha.
Privo
non solo
di qualsiasi ideologia (e questo si sa) ma
anche di qualsiasi visione di contenuto. A parte il “nuovo” e il
“cambiamento”.
Qualsiasi cosa contengano. E a parte il consenso, naturalmente: scopo
ultimo.
Unico, probabilmente.
I
miei amici di
sinistra che simpatizzavano per lui, ancora
un anno fa, dicevano che questo era proprio il suo lato positivo.
Perché era
«una scatola vuota che si poteva riempire con i nostri contenuti».
Ricordo
discussioni lunghissime in merito, a tavola e altrove. Erano convinti
che lo si
potesse direzionare nei contenuti sul lato dei diritti sociali e
civili,
acquisendo a quei diritti un consenso che andasse molto oltre i voti
abitualmente presi dalla sinistra in questo Paese. Quindi ne parlavano
come di
un’occasione d’oro. E consideravano i miei dubbi – allora erano solo
tali – i
borbottii di un pessimista.
Mah.
Ora si sta
vedendo come va, questa cosa qui. Altro che
riempirlo di contenuti di sinistra.
Perché
il
risultato inevitabile, in un contesto così, è che
invece il suo governo faccia in prevalenza cose di destra. Non perché
lui lo
sia, “di destra”: lui è solo “di Renzi”. Ma perché nel frattempo la
politica ha
perso potere. Tanto potere. C’è il “pilota automatico” di cui parlava
Draghi. E
quello, invece, è un pilota sicuramente di destra. Per fare qualcosa di
diverso
da ciò che vuole quel pilota, per modificarne almeno un pochino la
rotta,
servirebbe – appunto – una visione. Un progetto. Una direzione opposta.
E
non è questo
il caso.
Il
caso
invece è quello di una silenziosa divisione dei compiti. Da un lato il
pilota
automatico, che è quello che davvero impatta sulle nostre vite, che
impone le
sue regole su di noi. Dall’altro lui, che corre a zig zag ubriacando
tutti in
favore di telecamere, in cerca di un gol che si chiama solo consenso.
|
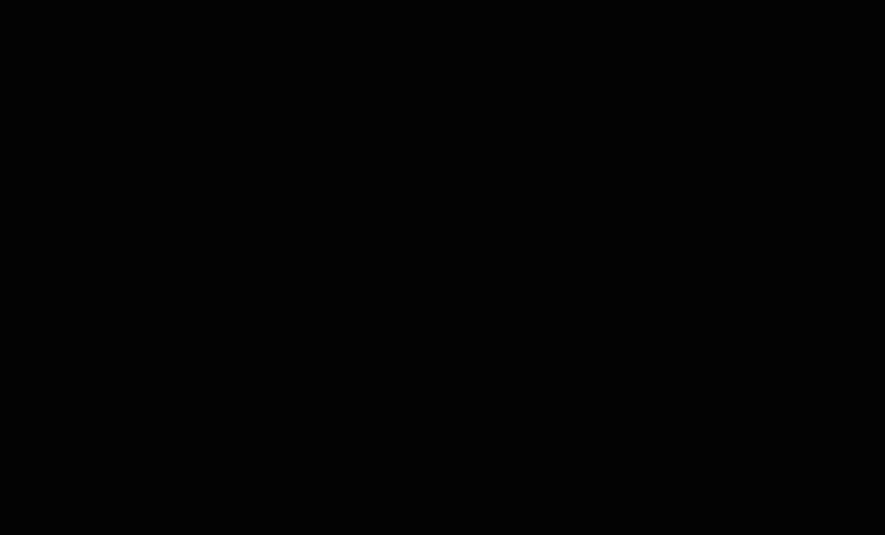
![]() 12
ottobre
2014
12
ottobre
2014